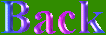
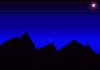
Strumenti
meteorologici:
Anemometro
(greco
anemos, “vento” e metron, “misura”), strumento che misura la velocità
del vento. Il modello più comune di anemometro è composto da tre o quattro
coppette saldate a un’asta verticale tramite corte barre; il flusso d’aria
spinge le coppe provoca la rotazione dell’asta con frequenza proporzionata
alla sua intensità. La velocità del vento può essere misurata anche
sfruttando la pressione dell’aria che entra in un tubo di Pitot (un tubo a
forma di L, avente un’estremità aperta al flusso d’aria e l’altro
collegata a un dispositivo di misurazione della pressione), o misurando la
variazione della resistenza di un filo conduttore in seguito all’abbassamento
di temperatura provocato dall’esposizione all’aria esterna.
Igrometro
Nome
dato a diversi tipi di strumenti per la misurazione dell’umidità atmosferica.
Un semplice modello di igrometro ,detto ad assorbimento è usato in abitazioni e
uffici,sfrutta le variazioni di lunghezza di una fibra naturale (ad esempio un
capello umano) provocate dall’umidità assorbita. L’allungamento della fibra
provoca il movimento di una lancetta, che indica
una percentuale di umidità
relativa. Questo tipo di strumento fornisce un’indicazione approssimata
dall’umidità, e non viene usato per accurate determinazioni quantitative.
Lo strumento più comunemente usato in laboratorio per misurare l’umidità
relativa è lo psicrometro, o termometro a bulbo umido e asciutto: due
termometri simili sono montati fianco a fianco; uno di essi, con il bulbo
asciutto è esposto direttamente dall’aria ambiente, mentre l’altro, avvolto
in una pezzuola, viene immerso in acqua. Il bulbo umido viene poi raffreddato
per effetto dell’evaporazione dell’acqua, ma la velocità di evaporazione,
è quindi la diminuzione di temperatura, dipendono dall’umidità atmosferica:
più secca è l’aria, più velocemente evaporata dall’acqua. Una tabella a
corredo dello strumento permette di stabilire
l’umidità relativa dal confronto delle
letture sui due termometri.
L’igrometro
a condensazione misura l’umidità relativa per mezzo del punto in cui avviene
la condensazione del vapore acqueo (punto di rugiada). Una piccola quantità di
etere etilico viene posta in una leggera coppa metallica: l’evaporazione
dell’etere, accelerata da una sottile corrente d’aria che è fatta penetrare
nel contenitore, fa abbassare la temperatura della coppa; quando la tempera tura
dell’aria circostante raggiunge quella del punto di rugiada, sulla parete
della coppa compare improvvisamente un velo di umidità. La temperatura viene
allora letta per mezzo di un termometro, e con l’aiuto della tabella di cui è
fornito lo strumento si può calcolare l’umidità relativa che corrisponde a
quella temperatura.
Termometro
Strumento
utilizzato per effettuare misurazioni di temperatura. Il tipo più comunemente
usato è quello al mercurio, costituito da un tubo capillare di vetro, a
diametro costante, che reca a una estremità un bulbo riempito di metallo
liquido, il tutto sigillato per assicurare un vuoto parziale nel capillare. Se
la temperatura aumenta, il mercurio si dilata e sale nel capillare: il livello
raggiunto fornisce una misura indiretta di temperatura, che viene letta su una
scala graduata propriamente tarata. Al posto del mercurio si possono usare
alcol, etere o altri liquidi.
L’invenzione del termometro è attribuita a Galileo , benché il tipo
sigillato sia apparso solo verso il 1950. I termometri moderni ad alcol e a
mercurio furono invece inventati dal fisico tedesco Gabriel Fahrenheit, a cui si
deve anche la scala di temperature che oggi porta il suo nome.
Tipi di
termometro
Esiste Un’ampia
varietà di dispositivi usati come termometri, tutti basati su un metodo di
misurazione indiretta, secondo il quale si assume che una variazione unitaria di
temperatura provochi un cambiamento analogo e proporzionale – con
proporzionalità costante – in una caratteristica di una grandezza fisica
facilmente misurabile; la variazione viene poi letta su una scala graduata
opportunamente tarata.
Nei termometri a resistenza si sfrutta il fatto
che la resistenza elettrica di un conduttore o di un semiconduttore varia sotto
il cambiamento della temperatura; in particolare, aumenta con la temperatura nel
primo caso e diminuisce nel secondo. Applicando una differenza di potenziale
costante a capi di un conduttore
è possibile dunque determinare il valore della sua temperatura a partire
dalla misura dell’intensità di corrente che lo attraversa e, mediante
opportuni collegamenti elettrici, leggere tale valore su un display digitale.
Misurazioni
molto accurate si ottengono con l’uso di termocoppie, sistemi costituiti da
due fili conduttori di materiale diverso saldati alle estremità: la differenza
di potenziale che si stabilisce ai capi della congiunzione dipende dalla
temperatura a cui essa si trova; la debole corrente che si stabilisce è dunque
una misura della temperatura, e può facilmente essere misurata.
Un
altro strumento per la misurazione della temperatura, usato principalmente nei
termostati, è basato sull’espansione termica differenziale tra due lamelle o
dischi di metalli diversi, collegate alle estremità.
Termometri
per usi speciali
Alcuni termometri possono
registrare la termometro minime o quelle massime raggiunte, ad esempio quelli
clinici, nei quali il mercurio rimane nella posizione raggiunta durante la
misurazione e torna indietro solo scotendo vigorosamente il termometro.
Le temperature massime raggiunte da macchine e utensili durante il funzionamento
possono essere stimate mediante l’ osservazione di vernici speciali che
cambiano di colore a seconda della
temperatura raggiunta, o, in generale, mediante sistemi ottici.
Accuratezza della misurazione
Una
misurazione accurata della temperatura dipende dal raggiungimento dell’
equilibrio termico tra il dispositivo termico e l’ ambiente circostante (
condizioni che si verifica quando non si verificano più scambi di calore tra il
termometro e l’ oggetto in contatto termico con esso ).
Qualsiasi termometro indica solo la propria
temperatura, che può non coincidere con quella effettiva dell’ oggetto da
misurare.
Nella misurazione della temperatura dell’ aria all’ esterno di un edificio,
ad esempio, due termometri posti molto vicini, ma in posizione diversa, ad
esempio uno all’ ombra e l’ altro al sole, forniranno letture molto diverse.
Per evitare tali errori, la determinazione accurata della temperatura richiede
la schermatura dei termometri da fonti di calore e di freddo alle quali, o delle
quali, il calore potrebbe essere trasferito per radiazione, conduzione o
convezione.
BAROMETRO
Strumento
impiegato per misurare la pressione atmosferica,cioè la forza esercitata
dall’atmosfera su una superficie di un’area unitaria. Benché tale forza si
trasmetta con uguale intensità lungo tutte le direzioni,la misurazione viene
generalmente condotta per mezzo di un confronto tra la pressione esercitata
dall’atmosfera e quella dovuta al peso di una colonna di liquido.
Si definisce pressione atmosferica normale o standard la pressione di 760 torr,corrispondente
al peso di una colonna di mercurio alta 760 mm,ed equivalente a 101,35 kPa
(1kPa,o kilopascal,è la pressione esercitata dalla forza di 1000 N su un metro
quadrato di superficie).
Un normale barometro a mercurio è costituito da un tubo di vetro alto circa
1m,chiuso all’estremità superiore e aperto a quella inferiore. Quando il tubo
è riempito di mercurio e l’estremità aperta è immersa in un contenitore
riempito con lo stesso liquido, il livello scende a un’altezza di circa 760mm
(rispetto al contenitore),lasciando un vuoto quasi perfetto nella parte superire
del tubo. Variazioni della pressione atmosferica fanno salire o scendere il
liquido di poco,raramente sotto ai 737mm o sopra ai 775mm a livello del mare. Il
risultato ottenuto con un barometro a mercurio,preciso entro un errore di circa
0,1mm,deve sempre essere corretto per tener conto delle variazioni della forza
di gravità con l’altitudine e la latitudine,e della dilatazione termica del
liquido;importante è anche la scelta del diametro del tubo,per evitare
l’insorgere di fenomeni di capillarità.
Altrettanto usato è il barometro aneroide,in cui la pressione atmosferica
incurva la parete elastica di un tamburo che può essere parzialmente
svuotato;dalla deformazione subita è possibile risalire al valore della
pressione esterna. Poiché la pressione diminuisce rapidamente con l’aumentare
dell’altitudine,questo strumento è spesso usato come altimetro (strumento
atto a misurare l’altitudine).
L’uso del barometro è fondamentale per formulare previsioni meteorologiche
accurate,possibili solo individuando dimensioni,forma e movimento delle masse
d’aria continentali,mediante simultanee osservazioni barometriche in punti di
osservazione distinti.