


 |
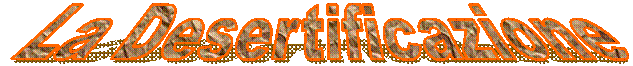
La
desertificazione è un fenomeno di progressivo degrado del suolo che avviene
nelle zone a clima arido, semiarido e sub-umido.
Il
suolo si impoverisce progressivamente delle sue proprietà chimico-fisiche che
lo rendono fertile e lavorabile, fino al punto di non riuscire a sostenere
l’insediamento di vegetali.
La
desertificazione di un territorio non va confusa con l’espansione dei deserti,
cioè la desertizzazione, poiché nel primo caso essa può verificarsi anche in
aree fortemente irrigate o situate lontano dalle regioni desertiche.
Il processo di degradazione del suolo deriva da una errata gestione del terreno cioè, dall’impiego di sistemi di coltivazione non adeguati alle condizioni climatiche e alle caratteristiche del suolo.
Quando
il carico di bestiame è superiore a quello che i pascoli possono sostenere,
alle specie vegetali perenni si sostituiscono specie annuali e arbusti di cui il
bestiame non si ciba; le specie erbacee regrediscono; il calpestio degli animali
altera irreversibilmente la superficie del terreno; infine, il suolo resta
esposto all’azione erosiva dei venti e delle acque.
I
terreni che non vengono lasciati riposare, quelli che vengono lavorati troppo in
profondità con mezzi meccanici e quelli coltivati a monocoltura (coltivazione
di una sola specie vegetale praticata per più anni su uno stesso terreno, in
genere finalizzata alle esportazioni), perdono progressivamente la loro fertilità.
Il
problema della desertificazione fu trattato per la prima volta in modo globale
nel 1956 quando, a Rio de Janeiro, si tenne il convegno dell’Unione
Internazionale dei geografi; il termine “desertificate” designava in quella
sede le regioni tropicali dell’Africa soggette ad un uso non corretto delle
risorse.
Successivamente
si tennero i meeting di Montreal del 1972 e di Mosca del 1976. Nel 1992, fu
adottata la “Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta contro la
desertificazione, nei paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla
desertificazione, in particolare in Africa”.
Di
desertificazione si occupano anche varie agenzie ONU tra le quali la FAO, il
programma ONU per lo Sviluppo (UNDP), l’Organizzazione Meteorologica Mondiale,
UNEP e UNESCO.
Secondo
le Nazione Unite, sono circa 110 i paesi
colpiti da desertificazione: sarebbero a rischio di desertificazione il 70%
delle terre aride coltivabili, pari a circa il 30% del totale delle terre
emerse.
Il
problema è particolarmente grave in Africa e nei paesi in via di Sviluppo di
Asia, America Latina, e Carabi, ma anche Stati Uniti, Australia, Europa
meridionale e orientale sono interrelati al fenomeno. Ad esempio, il 33% della
superficie dell’Europa è minacciata dalla desertificazione.
Secondo
il Ministero dell’Ambiente, che presiede il Comitato Italiano di lotta alla
desertificazione, circa il 27% del territorio e minacciato da processi di
inaridimento dei suoli.
In
particolare, il Mediterraneo settentrionale (Grecia, Italia, Portogallo, Spagna,
Turchia) è colpito da desertificazione.
Secondo
alcuni studiosi, le dimensioni del problema a livello planetario non sono state
valutate correttamente, anche a causa delle difficoltà di stimare con
precisione la superficie totale messa a rischio dalle attività umane.
Alcune iniziative, comunque,
hanno effettivamente contribuito a fermare il processo di desertificazione: in
alcune regioni poste ai margini del Sahara, ad esempio, sono state impiantate
“Cinture Vegetali” formate da schiere di alberi particolarmente resistenti.
Le
soluzioni adottate più di recente cercano, in particolare, di valorizzare i
poteri di intervento mirato a un determinato territorio, dando maggiore
importanza alle comunità locali, al ripristino di preziose pratiche agricole
tradizionali.
Inoltre,
mentre in passato si tendeva a cercare soluzioni di tipo prevalentemente
tecnico-agronomico, oggi si tende ad affrontare la globalità del problema,
spesso strettamente legata alla crescita demografica.
Silvia Tedeschi III M
Dopo
migliaia di anni di sfruttamento, l’uomo si è finalmente accorto che la terra
non è un pozzo senza fondo. Sono cominciate le iniziative per la salvaguardia
dell’ambiente. Mi sono resa conto dell’esistenza di alcune di queste
iniziative quando, durante queste vacanze, sono andata a visitare la mostra
allestita all’interno del Bioparco di Roma, chiamata “Furti di natura”.
Una
di queste iniziative è dedicata alla razionalizzazione dello sfruttamento del
legno, per limitare il fenomeno del disboscamento, spingendo ad adoperare, più
spesso, materiali come il bambù, che, rispetto all’albero, ha il vantaggio di
crescere più in fretta (2-3 anni) e in grande quantità (è una pianta
infestante come l’edera).
Un
altro esempio di azione promossa, è quello condotto nei confronti della vigogna
(un piccolo camelide) che un tempo veniva cacciato per la sua particolare lana,
e che invece, adesso, viene allevata e periodicamente tosata. Ciò, oltre a
portare vantaggio alla vigogna, ha portato un guadagno economico consistente
anche alle popolazioni locali. Io ritengo che queste azioni dovrebbero essere
allargate il più possibile a tutti gli aspetti dell’ambiente naturale, per
evitare, ad esempio, l’estinzione di alcuni animali come l’elefante,
ricercato per l’avorio, o la tigre, le cui parti del corpo vengono usate nelle
medicine orientali.
Infine,
un altro grosso problema per l’equilibrio dell’ambiente, è il commercio
illegale di animali e piante. Spesso i turisti, tornando dalle vacanze, portano
via, a volte inconsapevolmente, parti di animali o piante o, addirittura,
animali vivi. Questi vengono poi sequestrati alle frontiere e per questo motivo
non possono neanche essere reintegrati nel loro ambiente.
Spero, comunque, che in futuro si possa ancora migliorare con questo tipo di interventi e, soprattutto, spero che cresca nelle persone la consapevolezza che la nostra terra è un patrimonio da proteggere e non da saccheggiare.
Nella
mia città, Ladispoli, il W.W.F. ha instaurato, nel bosco di Palo, un’oasi
privata naturale. Il W.W.F. (Fondo Mondiale per la Natura), dal 1980, su
un’area privata di proprietà dei principi Odescalchi, gestisce quello che
oggi è l’ultimo esempio di foresta plonizoria.
L’INQUINAMENTO
L’inquinamento è in genere una conseguenza non intenzionale e indesiderata delle attività umane: produzione industriale, trasporti, agricoltura, pesca ed eliminazione dei rifiuti. L’aumento preoccupante dell’inquinamento negli ultimi due secoli è stato il risultato dell’industrializzazione, della urbanizzazione e del rapido aumento della popolazione del pianeta. Le tecniche studiate per prevenire, sanare o mitigare i danni apportati all’ambiente dall’uomo costituiscono un ramo dell’ecologia. Esistono vari tipi di inquinamento ognuno causato da diversi fattori, legati quasi sempre alle attività dell’uomo.
L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO è l’emissione nell’atmosfera di sostanze potenzialmente nocive agli ecosistemi. Gli inquinanti primari sono generati direttamente dall’attività umana o da fenomeni naturali mentre gli inquinanti secondari si formano a causa dell’interazione tra gli inquinanti primari e altri componenti dell’atmosfera, per esempio la radiazione ultravioletta proveniente dal sole.
L’INQUINAMENTO DELLE ACQUE. Fiumi, laghi e falde acquifere possono essere inquinati dal rilascio di sostanze chimiche dannose per gli organismi acquatici, per esempio detergenti e composti tossici scaricati direttamente nell’acqua da impianti industriali. Le fonti di inquinamento più diffuse sono i liquami non depurati e le sostanze chimiche usate nell’agricoltura: fertilizzanti, pesticidi e erbicidi. L’inquinamento del mare oltre che dal deflusso delle acque interne inquinate, è causato dallo scarico diretto operato senza efficaci depurazioni da industrie e insediamenti urbani e costieri e dalla eliminazione di rifiuti da parte di imbarcazioni. Inoltre gran parte di inquinanti atmosferici finisce prima o poi per precipitare in mare. Il mare può essere gravemente contaminato anche a grande distanza dalle coste; l’inquinante più diffuso è il petrolio a causa della pratica difettosa di scarichi in mare dalle petroliere le acque di lavaggio delle cisterne, e dai ripetuti incidenti che coinvolgono petroliere e piattaforme di estrazione.
L’INQUINAMENTO DEL SUOLO è dovuto principalmente alla dispersione nel terreno di rifiuti solidi che non sono biodegradabili o la cui decomposizione richiede intervalli di tempo molto lunghi, per esempio i contenitori in plastica in alluminio.
L’INQUINAMENTO CHIMICO. Tra i principali esempi di inquinamento chimico ci sono il rilascio nell’ambiente di metalli pesanti (piombo o mercurio) utilizzati in molti processi industriali e l’uso dei pesticidi. Questi elementi e composti possono danneggiare interi ecosistemi, propagandosi attraverso le catene alimentari. L’aumento dei livelli di rumore associato alla vita nella società industrializzata e portato a coniare il termine.
L’ INQUINAMENTO TERMICO. Si parla di inquinamento termico quando si ha un rilascio localizzato di grandi quantità di calore nell’ambiente. E’ il caso, per esempio, dei sistemi di raffreddamento di complessi industriali, o centrali per la produzione di energia, collocati sulle rive dei fiumi. Gli scarichi possono innalzare significativamente la temperatura a valle dell’impianto, determinando cambiamenti anche radicali dell’ecosistema acquatico.
Patrizia Daszkilewicz
e Antonio Capriglia II C
TSUNAMI O MAREMOTO
La traduzione dal giapponese significa "onda nel porto".
Si tratta di una serie di onde che si generano in seguito a movimenti improvvisi del fondale marino dovuti a terremoti, eruzioni vulcaniche sottomarine, frane, impatti meteoritici.
La maggior parte degli Tsunami che si verificano nell’Oceano Pacifico, interessa porzioni limitate di costa e provoca danni di lieve entità.
Gli Tsunami più devastanti sono provocati da forti terremoti generati da spostamenti verticali (sollevamento o sprofondamento) della crosta terrestre lungo faglie e bordi della piattaforma Oceanica. Questi maremoti distruggono i centri abitati i loro effetti si risentono su tutto il bacino dell’Oceano Pacifico.
Sono fenomeni rari che si verificano con cadenza decennale.
Uno di questi si verificò il 22 Maggio 1960 e portò morte e distruzione sulle coste del Pacifico dal Cile alle Hawaii e dal Giappone alle Filippine.
Non tutti i terremoti generano Tsunami e da oggi non c’è modo di poterlo prevedere.
Alle stazioni che studiano il moto ondoso giungono però delle onde caratteristiche. Lo Tsunami si propaga dall’epicentro in tutte le direzioni ma con energia maggiore perpendicolarmente alla linea di frattura che ha generato il terremoto.
La velocità dipende dalla profondità.
In oceano aperto, con alte profondità, la velocità varia tra i 500 e i 1000 Km/ora. Le normali onde hanno velocità di circa 90 Km/ora.
La distanza massima tra due creste l’onda può variare tra i 500-650 Km.
Le onde oceaniche normali hanno lunghezze intorno ai 100 m.
Tra il passaggio di una cresta e la successiva intercorrono tra 10 e 45 min. Il movimento può continuare per ore e non è detto che la prima ondata sia più intensa.
L’altezza delle onde in oceano aperto è di soli 30-60 cm.
Con queste dimensioni e l’enorme lunghezza, queste onde passano inosservate anche da barche, navi ed aerei.
Risultano ben visibili anche in oceano aperto solo quando la velocità di propagazione è particolarmente forte in una direzione rispetto alle altre.
La forza e potenza dello Tsunami deriva dal fatto che si tratta di onde che interessano l’intera colonna d’acqua, dalla superficie al fondale.
Quando lo Tsunami raggiunge la costa, la velocità delle onde diminuisce e l’altezza aumenta. Può formarsi un vero e proprio muro d’acqua con altezze che facilmente superano i 10 m. L’onda più alta di cui si ha notizia, 60 m, si abbattè sulla baia di Lituya in Alaska nel 1958. Gli effetti variano in base al tipo di costa, al fondale e alla batimetria.
Il primo segnale dell’arrivo di uno Tsunami è il risucchio dell’acqua verso il largo o il lento innalzamento del livello dell’acqua che continua per 10-15 min.
La forza e la distruzione sono legate sia al fronte turbolento dell’onda che si infrange alla potenza delle correnti che si generano.
Le barche e tutto quello che si trova sulla costa, possono essere sollevate e scaraventate contro i frangiflutti o spinte sulla terra ferma.
Le acque basse delle baie e dei porti evidenziano per prime l’arrivo dello Tsunami.
Dal 1900 al 2000 se ne sono verificati 796 nel Pacifico. Non ci sono stati anni senza maremoti.
117 hanno provocato danni solo nelle vicinanze della sorgente.
9 hanno causato devastazioni estese a tutto il Pacifico.
Il 1938 è stato l’anno in cui si sono registrati più Tsunami (19), fortunatamente tutti di debole intensità e senza danni.
17% degli Tsunami si genera vicino al Giappone. A seguire, sud-America 15%, Nuova Guinea e isole Solomon 10%,
Filippine 9%, Nuova Zelanda e Tonga 7%, Alaska e costa occidentale, Canada, Stati Uniti 7%, Hawaii 3%.
Recenti Tsunami:
2 Settembre 1992 Nicaragua max altezza 10 m – 170 morti.
12 Luglio 1993 Hokkaido max altezza 30 m – 200 morti.
2 Giugno 1994 Java max altezza 14 m – 220 morti.
21 Febbraio 1996 Perù max altezza 5 m – 12 morti.
17 Luglio 1998 Nuova Guinea max altezza 15 m – 2000 morti.
23 Giugno 2001 Perù max altezza 5 m – 50 morti.
File:
Nostro ambiente