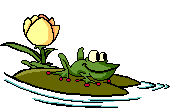|
Breve storia delle abitudini dell’uomo… Cari amici, aprire un rubinetto ed avere subito tutta l' acqua che ci serve è per noi gesto talmente naturale che lo facciamo senza riflettere. Soddisfiamo le nostre necessità fisiologiche ed igieniche (e anche qualcosa di più) con una semplice operazione, dietro la quale però c'è un complesso sistema di cui noi vediamo solo il risultato finale, l'acqua, e la costruzione più frequente: il serbatoio dell' acquedotto. L'acqua che arriva nelle nostre case deve avere particolari caratteristiche, tra le quali la più importante: deve essere potabile. Tuttavia sempre più persone preferiscono non utilizzare l'acqua dell'impianto domestico per bere ma acquistano una delle tante acque minerali presenti sul mercato. Si tratta di una scelta personale, dettata dalla speranza di avere così acqua di qualità migliore, ma non sempre giustificata. Ora poniamoci una domanda: LAVARSI O NON LAVARSI ? Il modo di considerare l'acqua si è fondato sui riti di purificazione e l'acqua è spesso stata presa a simbolo di purezza, tuttavia non mancano testi letterari e pregiudizi popolari che ne sottolineano invece gli aspetti negativi. Nel Settecento si pensava che il lungo contatto con l'acqua ostruisse i pori, evitasse la traspirazione e rendesse il sangue denso, inoltre per molti secoli, dopo l'abbandono dell'abitudine del bagno che era stata tipica dei Romani, la pulizia del corpo è stata considerata poco morale!!! Per lunghi secoli la medicina ha attribuito all'umidità dell'acqua una valenza negativa, accusandola di aprire i pori e quindi di aprire la via alle infezioni dall'esterno. Nel medioevo l'etichetta prescriveva di lavarsi la faccia ogni mattina, ma non faceva mai riferimento a bagni completi. Dal 1500, quando la peste si ripresenta con regolarità, l'acqua viene accusata di ogni nefandezza; fare il bagno debilita e quindi espone al rischio di malattie per cui, chi proprio vuole lavarsi, almeno limiti i danni prendendo precauzioni, come ad esempio non uscire di casa per alcuni giorni ed osservare riposo assoluto. Certamente non si lavino mai bambini! La pulizia del corpo è affidata alla "pulizia secca", cioè al cambio dei vestiti, secondo il principio per cui una camicia pulita corrisponde ad un bagno. In realtà poi alla paura di malattie si accompagna a lungo la paura del peccato, in quanto l'igiene personale presuppone la vista ed il contatto con parti del corpo e quindi espone a rischi morali. Solo a partire dal Settecento cominciano a diffondersi pratiche igieniche, e solo nell' aristocrazia; l'abitudine alla pulizia si diffonderà tra i ceti popolari nel tardo Ottocento, un po' per imitazione, un po' perché solo quando l'acqua sarà convogliata all'interno delle abitazioni perderà le caratteristiche di elemento prezioso e costoso riservato a pochi. D'altra parte solo un ambiente che permette di lavarsi senza una forzata promiscuità può rendere il bagno un'abitudine. In Italia, fino alla fine degli anni cinquanta, fare il bagno risultava problematico per la mancanza di ambienti idonei e per l'assenza di un impianto di riscaldamento; in genere l'ambiente usato era la cucina e non era infrequente che la stessa acqua servisse per più persone. Ma anche come bevanda l'acqua ha spesso suscitato sospetti e rifiuto. Molti proverbi popolari esaltano il vino come antidoto alle più svariate malattie e attribuiscono all'acqua il potere di accorciare la vita e di provocare malinconia e tristezza. Anche molti medici, fino all'Ottocento, individuavano nelle sostanze contenute nell'acqua le responsabili di molte malattie come il cretinismo, il gozzo, le febbri "miasmatiche", e queste credenze per secoli hanno condizionato la cultura e la vita quotidiana delle popolazioni. Credenze inconcepibili, alla luce delle nostre conoscenze scientifiche, ma ineccepibili, se si considerano i rischi delle malattie gastroenteriche che si trasmettono attraverso l'acqua contaminata o il rischio di contrarre malaria nelle zone con acque stagnanti. |
 |