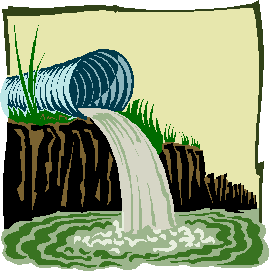
INQUINAMENTO
DELL'ACQUA
A
causa della sua estrema fluidità e della sua estensione nel globo, l'acqua
costituisce, insieme all'atmosfera, uno dei veicoli più importanti
dell'inquinamento ecologico.
Nonostante l'imponente sviluppo delle reti stradali e il crescente utilizzo dei
mezzi aerei, le vie d'acqua (soprattutto il mare ma anche le vie fluviali e
lacustri) restano ancora quelle che assicurano i mezzi più economici e talora
insostituibili per il trasporto delle merci. Basta pensare al trasporto
dei carburanti dai centri di produzione ai centri di lavorazione e di consumo.
Oltre che come via di comunicazione, l’uomo ha sempre utilizzato il mare come
un grande scarico naturale, ma per millenni ciò non ha comportato danni molto
gravi. Fino ad un centinaio di anni fa i fiumi, insieme ai materiali strappati
alle rocce, immettevano in mare le sostanze organiche contenute nelle acque
residuali urbane che contenevano sostanze organiche e batteri. Le sostanze
organiche non erano troppo abbondanti e giunte al mare venivano rapidamente
riutilizzate come nutrimento dagli organismi del plancton. I batteri venivano
diluiti e non riuscivano a sopravvivere a causa della salinità e della
temperatura. I rifiuti industriali erano relativamente poco dannosi essendo
costituiti quasi esclusivamente da sostanze biodegradabili e da pochi elementi
metallici. La capacità depurativa del mare superava la capacità inquinante
delle sostanze immesse.
Oggi la situazione è profondamente mutata: nell’ultimo secolo la popolazione
mondiale è cresciuta enormemente e si è andata concentrando nelle aree urbane.
Gli scarichi organici di produzione umana si sono notevolmente accresciuti. Gli
stabilimenti industriali si sono moltiplicati e nell’elenco dei loro rifiuti
sono entrate sostanze chimiche artificiali non trasformabili, derivate dalla
lavorazione delle materie plastiche, delle fibre sintetiche, di detergenti,
insetticidi e pesticidi. Ai metalli tradizionali se ne sono aggiunti altri
spesso molto tossici come il mercurio, il cadmio, il nichel, lo zinco, il cromo,
l’arsenico.
Anche l’agricoltura ha cominciato a dare il proprio contributo immettendo nei
fiumi acque cariche di fosfati e nitrati e contaminate da insetticidi, pesticidi
e diserbanti. Tutte queste sostanze contaminano sia le acque continentali che
quelle marine, producendo effetti, anche a distanze notevoli dalle zone di
scarico sulla flora e sulla fauna, con gravi pericoli anche per l’uomo.
L'Italia, in un mare semichiuso qual è il Mediterraneo, ha uno sviluppo
costiero di 8400 chilometri su cui risiedono circa 8 milioni di abitanti. Si
calcola che durante la stagione estiva questa popolazione si raddoppia o quasi.
L'intera zona costiera mediterranea conta una popolazione residente che può
essere calcolata in 27 milioni di persone. Le popolazioni costiere tendono ad
aumentare non solo a causa del fenomeno del turismo ma anche per l'incremento di
nuove industrie e lo sviluppo di quelle già insediate.
Riepilogando, oggi l'inquinamento dell'acqua è dovuto a tre cause principali:
1)
agli scarichi cloacali diretti (senza l'intervento di depuratori) nei fiumi, nei
laghi e nel mare;
2) a scarichi di rifiuti civili, industriali e agricoli;
3) a scarichi di oli combustibili provenienti da raffinerie o da lavaggi di
petroliere; cui vanno aggiunte perdite accidentali di idrocarburi.
Scarichi cloacali diretti
Gli scarichi urbani costituiscono il 59,2 per cento delle
fonti di inquinamento delle acque. Si può affermare che gli scarichi urbani
giungono quasi nella loro totalità al mare in condizioni organiche inalterate e
sovente in condizioni di difficile trasformazione. Le acque di scarico non
depurate contengono agenti patogeni (parassiti e batteri) e materiali organici
che per decomporsi assorbono una notevole quantità di ossigeno.
Lo scarico incontrollato delle acque residuali trasforma le acque costiere in un
ambiente favorevole alla sopravvivenza in concentrazioni massicce di batteri
fecali e di numerosi germi patogeni che quasi sempre li accompagnano.
I batteri aerobi consumano l’ossigeno disciolto nell’acqua per degradare il
materiale organico inquinante ma in questo modo creano un ambiente diverso, più
povero di ossigeno. Se il corpo idrico ricevente è poco profondo e
sufficientemente movimentato, l’ossigeno atmosferico può compensare quello
consumato, e l’anidride carbonica prodotta dalla decomposizione può
disperdersi nell’atmosfera. Al contrario, se il corpo idrico ricevente è
particolarmente calmo o addirittura stagnante, viene consumato più ossigeno di
quanto se ne sciolga e si ha un incremento dell'anidride carbonica disciolta.
Questa situazione causa la morte dei pesci e degli altri organismi che
hanno bisogno di ossigeno per vivere, incrementando così la quantità di
materia organica da degradare. Gli inerti e i rifiuti di plastica aggravano
questa situazione.
La presenza di microrganismi patogeni è anche indirettamente dannosa per la
salute umana in quanto questi possono contaminare i prodotti della pesca che
fanno parte dell’alimentazione umana. I prodotti della pesca provenienti da
zone inquinate spesso sono all'origine di epidemie di tifo, colera, salmonellosi
e altre malattie infettive.
Nei corpi d'acqua inquinati può essere presente ammoniaca, che deriva
principalmente dalla decomposizione microbica delle proteine. In presenza di
ossigeno l’ammoniaca viene ossidata a nitrati e nitriti, i quali una volta
consumato l’ossigeno vengono ridotti ad azoto gassoso. Contemporaneamente i
batteri anaerobi utilizzano l’ossigeno presente nei solfati, per produrre
idrogeno solforato (H2S )dal caratteristico sgradevole odore di uova marce.
Vengono prodotti anche CO2, idrogeno gassoso, e metano.
Scarichi di rifiuti civili, industriali e agricoli
Gli scarichi urbani ed extraurbani sono spesso saturi di
sostanze tensio-attive (detergenti) utilizzate sia per uso domestico sia
industriale. Le sostanze tensio-attive non sono biodegradabili e formano sulla
superficie dell'acqua uno strato galleggiante che impedisce lo scambio di
ossigeno con l'atmosfera e il passaggio in quest'ultima delle sostanze gassose
(anidride carbonica, metano, acido solforico, ammoniaca) che si formano dalla
decomposizione delle materie nell'acqua.
Per questo motivo la legge impone che i detersivi siano biodegradabili
all’80%.
In Italia il consumo dei detersivi si aggira sulle 500.000 tonnellate all'anno
per il solo uso domestico. Ma i detersivi trovano impiego anche nell'industria
tessile, nelle industrie alimentari, nelle birrerie, nelle lavanderie, nelle
pelliccerie, nell'industria del cuoio, nelle industrie metallurgiche, ecc.
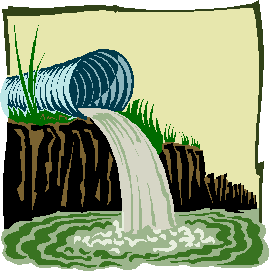
Gli
scarichi industriali contengono una grande varietà di inquinanti e la loro
composizione varia a seconda del tipo di processo produttivo. Il loro impatto
sull'ambiente è complesso: spesso le sostanze tossiche contenute in questi
scarichi rinforzano reciprocamente i propri effetti dannosi e quindi il danno
complessivo risulta maggiore della somma dei singoli effetti.
Gli effetti dei metalli tossici come mercurio, arsenico, cadmio, e piombo sono
molto dannosi.
Tra i rifiuti industriali si possono indicare gli scarichi galvanici e,
particolarmente nocivi, quelli provenienti da industrie che fabbricano prodotti
a base di mercurio o che utilizzano il mercurio nel ciclo di produzione. Il
mercurio inorganico contenuto negli scarichi industriali, tende a
depositarsi sul fondo di fiumi e laghi e nel mare. I batteri anaerobi lo
convertono in metil mercurio (CH3)2Hg, il quale causa seri danni al sistema
nervoso e al cervello degli animali e dell’uomo, e può provocare anche delle
mutazioni genetiche. Il mercurio infatti altera per assorbimento gli organismi
viventi nell'acqua ed è noto che il consumo di pesce pescato in zone inquinate
da mercurio ha causato la comparsa di una particolare forma morbosa chiamata in
Giappone «malattia di Minimata», dalla città costiera in cui fu per prima
accertata.
Vi sono altresì i residui delle concerie, delle cartiere, delle industrie
metallurgiche, delle fabbriche di coloranti e di caucciù sintetico, delle
fabbriche di materie plastiche e, in una parola, può dirsi, di ogni attività
industriale, nessuna esclusa.
Attraverso i prodotti della pesca possono giungere all’organismo umano metalli
tossici che una volta depositati in mare percorrono tutta la catena alimentare.
La concentrazione di inquinanti può essere ridotta limitandone la produzione
all'origine, sottoponendo il materiale a trattamento preventivo prima di
scaricarlo nella rete fognaria e recuperando le sostanze che possono essere
reintrodotte nei processi produttivi.
Lo scarico delle acque utilizzate nei sistemi di raffreddamento o di
riscaldamento di impianti industriali e di centrali elettriche provoca
alterazioni della temperatura che possono compromettere l'equilibrio ecologico
degli ecosistemi acquatici e causare la morte degli organismi meno resistenti,
accrescere la sensibilità di tutti gli organismi alle sostanze tossiche,
ridurre la capacità di autodepurazione delle acque, aumentare la solubilità
delle sostanze tossiche e favorire lo sviluppo di parassiti.
L’inquinamento da sostanze radioattive è dovuto alle esplosioni atomiche,
agli scarichi ed alle perdite delle centrali nucleari, ai rifiuti e alle scorie
degli impianti di utilizzazione e di ritrattamento dei materiali radioattivi, ai
sommergibili e alle navi a propulsione nucleare e alle altre applicazioni
pacifiche dei radioisotopi.
Le attività agricole sono un'altra importante fonte d'inquinamento delle acque.
Tale inquinamento è dovuto all'uso sempre più diffuso di insetticidi,
erbicidi, fertilizzanti. I fertilizzanti e altre sostanze chimiche favoriscono
una crescita eccessiva di alghe e piante acquatiche. Un'alta percentuale di
fertilizzanti (tra il 20 e il 25 per cento) non viene assorbita dal ciclo
produttivo e si immette direttamente, o per assorbimento attraverso i terreni,
nei corsi d'acqua per poi scaricarsi nel mare.
I fertilizzanti chimici usati in agricoltura e i liquami prodotti dagli
allevamenti sono ricchi di sostanze organiche (contenenti soprattutto azoto e
fosforo) che, dilavate dalla pioggia, vanno a riversarsi nelle falde acquifere o
nei corpi idrici superficiali. A queste sostanze si aggiungono spesso detriti più
o meno grossolani che si depositano sul fondo dei bacini. Il cadmio presente in
certi fertilizzanti può essere assorbito dalle colture e giungere
all'uomo attraverso la catena alimentare; se assunto in dosi elevate, può
provocare forti diarree e danneggiare fegato e reni.
I liquami di origine animale vengono scaricati a volte direttamente sul terreno
e da qui sono trasportati dall'acqua piovana nei fiumi, nei laghi e nelle falde
sotterranee.
Nei moderni depuratori i liquami passano attraverso tre fasi distinte di
trattamento.
La prima fase comprende una serie di processi fisici o meccanici di rimozione
dei detriti più grossolani; durante questa fase vengono anche fatti depositare
i sedimenti in sospensione e si separano le sostanze oleose.
Nella seconda fase si ossida la materia organica dispersa nei liquami per mezzo
di fanghi attivi o filtri biologici.
La terza fase ha lo scopo di rimuovere i fertilizzanti per mezzo di processi
chimico-fisici, come l'assorbimento su carbone attivo.
In ogni fase vengono prodotte notevoli quantità di fanghi, il cui trattamento e
smaltimento assorbe il 25-50% dei costi di impianto e di esercizio di un comune
depuratore.
Scarichi di oli combustibili
La terza causa dell'inquinamento dell'acqua, e quasi esclusivamente
delle acque marine, è dovuta agli idrocarburi. L'inquinamento da idrocarburi può
avere sia cause permanenti, sia cause accidentali e dolose.
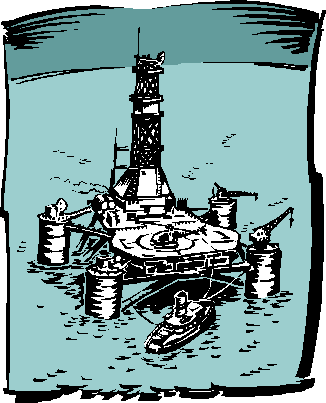
I
porti e i punti di scarico del petrolio grezzo o dei prodotti raffinati
costituiscono una causa permanente di inquinamento, cui contribuiscono
sensibilmente i cantieri di demolizioni navali.
Petrolio ed altri idrocarburi vengono versati frequentemente in mare dalle
raffinerie rivierasche, a causa di perdite incontenibili che sono molto piccole
se considerate singolarmente ma diventano ingenti quando si protraggono nel
tempo.

Ed
ancora più grave è lo scarico delle acque di lavaggio delle petroliere,
eseguito deliberatamente e spesso a poca distanza dalle coste; peraltro queste
navi subiscono talvolta incidenti che fanno riversare in zone ristrette
quantitativi enormi di petrolio greggio.
Si calcola che in tutto il mondo, lavorando e trasportando petrolio, ne
finiscano in mare 1.500.000 tonnellate all'anno.
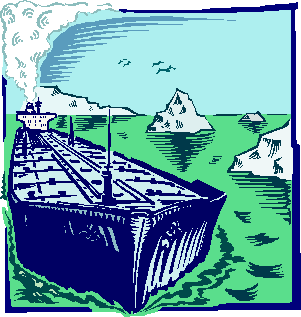
Ma,
mentre le cause permanenti di inquinamento in quanto previste e prevedibili,
possono venir contenute, disciplinate e più facilmente perseguite, le cause
accidentali costituiscono l'aspetto del fenomeno non solo più appariscente ma
anche più pericoloso, perché conseguenza di eventi improvvisi, non sempre
tempestivamente accertabili nella localizzazione e nella dimensione.
Il pericolo maggiore è rappresentato dagli incidenti che non di rado
interessano le superpetroliere. Nel 1978 la petroliera Amoco Cadiz riversò in
mare, al largo delle coste francesi, 1,6 milioni di barili di greggio. I 240.000
barili di greggio riversati dalla Exxon Valdez nella baia di Prince William, nel
marzo del 1989, si estesero in tutta l'insenatura formando una macchia oleosa di
ben 6770 km2 che compromise l'esistenza di molte specie marine e danneggiò
gravemente non solo gli ecosistemi locali, ma anche l'attività di pesca nella
zona.
I
milioni di barili di petrolio riversati nel golfo Persico nel corso della guerra
tra Iran e Iraq, nel 1983, e della guerra del Golfo, nel 1991, hanno causato
gravi danni all'intero bacino e compromesso l'esistenza di interi ecosistemi
marini.
Nell'acqua
gli idrocarburi formano ampie macchie galleggianti che possono essere attaccate
lentamente da organismi microbici assai rari e da processi fotochimici. Il
risultato è comunque una sottrazione di ossigeno all’ambiente sia perché il
petrolio galleggiante impedisce all’ossigeno atmosferico di raggiungere le
acque marine sottostanti, sia perché i batteri per degradarlo consumano
notevoli quantità di ossigeno.
Eutrofizzazione
L’eutrofizzazione è un fenomeno connesso
all’eccessivo apporto di sostanze nutrienti in uno specchio d’acqua che
provoca un’abnorme proliferazione di vegetazione sommersa. Le variazioni della
quantità di organismi vegetali presenti in un ambiente acquatico sono
determinate dalla disponibilità di elementi nutritivi (carbonio, fosforo,
azoto, microelementi). Apporti elevati di azoto e fosforo, derivanti nella
maggioranza dei casi dalle attività umane, determinano la produzione di enormi
quantità di vegetazione in laghi e in mari poco profondi (per esempio,
l’Adriatico).
La sedimentazione sul fondo e la decomposizione
della massa vegetale esuberante innescano una serie di effetti negativi, quali
la scomparsa dell’ossigeno disciolto nelle acque di fondo e la conseguente
morte di organismi o lo sviluppo di gas tossici. In particolari condizioni
stagionali (soprattutto in autunno e primavera), le acque di fondo prive di
ossigeno possono mescolarsi con quelle superficiali ossigenate, creando una
miscela il cui contenuto di ossigeno è così basso (2-3 mg/l) da non essere
compatibile con la vita dei pesci. Si verificano allora imponenti morie,
soprattutto a carico delle specie che necessitano di più elevati apporti di
ossigenazione (trote, coregoni).