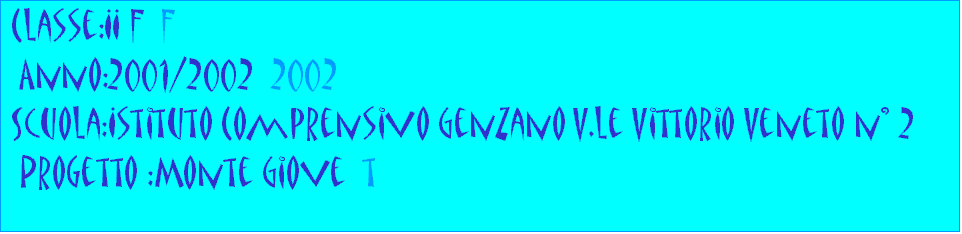
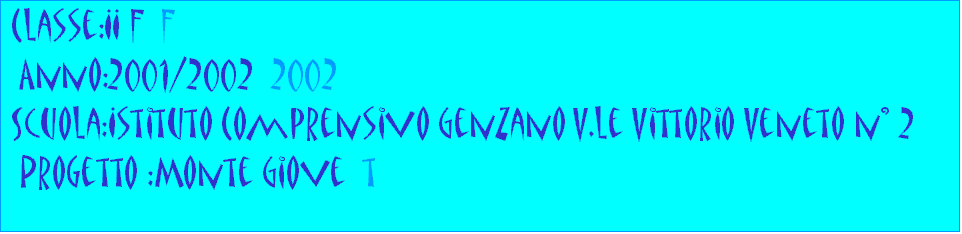
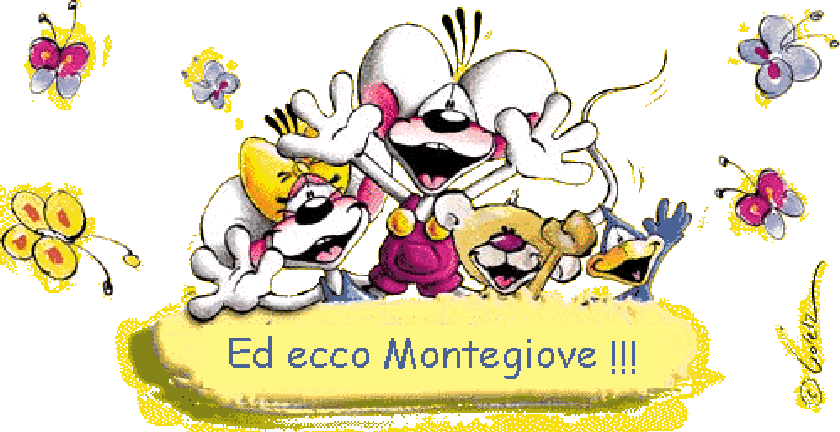
| CONTESTO URBANO | |
|
Monte
Giove o Monte due Torri fu chiamato
così per l'esistenza di due torri di origine medioevale, di cui l'ultima fu
distrutta durante l' ultimo conflitto mondiale. |
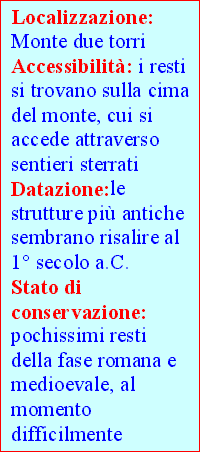 |
Sulla
collina sorgeva il castello. Il castello doveva essere recintato da una cinta di
mura, nel ripiano superiore e anteriore. La piattaforma su cui anticamente il
castello sorgeva, è di forma rotonda e al centro di essa sono presenti i resti
di una costruzione romana rettangolare di calcestruzzo. Essa è fiancheggiata
per tre lati da una specie di corridoio, di cui restano le pareti. Davanti a
questa costruzione sorgeva una torre quadrata, alta circa 20m.
Contrapposta
ad essa c'era l'altra torre, uguale alla prima, che è crollata durante gli
ultimi eventi bellici. Ne rimane in piedi un avanzo che nel punto più alto
raggiunge i 6m. Ha un apertura in basso forse moderna. Intorno ci sono due
enormi blocchi di peperino, uno dei quali doveva trovarsi sulla soglia del
monumento romano.
Sparsi
sulla collina ci sono blocchi di marmo squadrati.
Contesto territoriale
Il
toponimo di Monte due Torri trae origine dall'esistenza di due torri, poste
sulla sommità del colle. Il monte due torri, prodotto dall'attività eruttiva
del Vulcano Laziale, si presenta come un rilievo dalla forma regolare che
raggiunge i 415m. tra la vasta pianura incisa dai numerosi fossi del versante
ardeatino.
I RESTI SULLA CIMA DEL MONTE
Agli inizi del secolo era ancora visibile la piattaforma, su cui anticamente sorgeva il castello. Questa era di forma più o meno circolare ed al centro si notavano resti di una costruzione rettangolare in opus incertum di circa metri 15x20. Era fiancheggiata per tre lati da una specie di corridoio, di cui restavano le pareti in opus reticolatum, qualche traccia del pavimento in opus spicatum e, sulla soglia dell'ingresso, verso sud, due grandi blocchi di peperino squadrato. Altri avanzi del pavimento si trovano davanti alla soglia e fuori della costruzione. Davanti alla costruzione, all'angolo sud- ovest, si ergeva una delle due torri. Essa era a base quadrata, alta circa 20 metri, senza copertura, in piccoli parallelepipedi di peperino, con nove ripiani di fori per le travature e con tre finestrine rettangolari situate in alto. Contrapposta ad essa, a sinistra degli avanzi della costruzione romana, si trovano i resti dell'altra torre, simile alla prima, crollata nel XVIII secolo. Ne rimaneva in piedi un lacerto che nel punto più alto raggiungeva i 6 metri di altezza. Sparsi sulle pendici della collina si notavano numerosi blocchi di peperino e di marmo squadrati. Si è ipotizzato che il complesso delle strutture fosse provvisto di una duplice cinta fortificata articolata su due livelli distinti.
NOTIZIE STORICO CRITICHE
Livio (VI, 2) e Plutarco (Vita di Camillo 34, I-5) ci
narrano che nell'anno 389 a.C., a causa delle ripercussioni interne dovute alla
invasione gallica; Roma si trovò in contrasto con le popolazioni confinanti:
gli Etruschi, i Latini ed i Volsci, che ritenevano che le forse di Roma fossero
rimaste fiaccate da quell'episodio. La città si affidò per la difesa a Camillo
che, diviso l'esercito in tre parti
e preso il comando di una di esse, si mosse contro i Volsci sconfiggendoli in
una località, non lontana da Lanuvium, chiamata ad Maecium. Circa la
localizzazione di questo luogo, che doveva essere stato un nucleo urbano si è
aperta in passato una vera e propria querelle tra gli studiosi. Va sottolineato,
infatti, come l'ubicazione del MONS MAECIUM sia del tutto incerta. L'unico dato
disponibile per l'identificazione è una notizia tramandataci
da Diodoro Siculo, secondo la quale la suddetta località distava da Roma
200 stadi e, in estate, era esposta a forti venti. I due grandi studiosi Nibby e
Tomassetti identificarono il Mons Maecium con Monte due Torri.
Il casale S. Martino
Nel sito dove attualmente ha sede un'azienda agrituristica, i FRATI CARMELITANI di SAN MARTINO ai MONTI costruirono un casale sopra i resti di una cisterna romana, avendone ottenuta l'enfiteusi dal Duca Filippo Cesarini. Alcuni studiosi ipotizzano che la cisterna fosse una via di comunicazione tra Roma e Lanuvio.