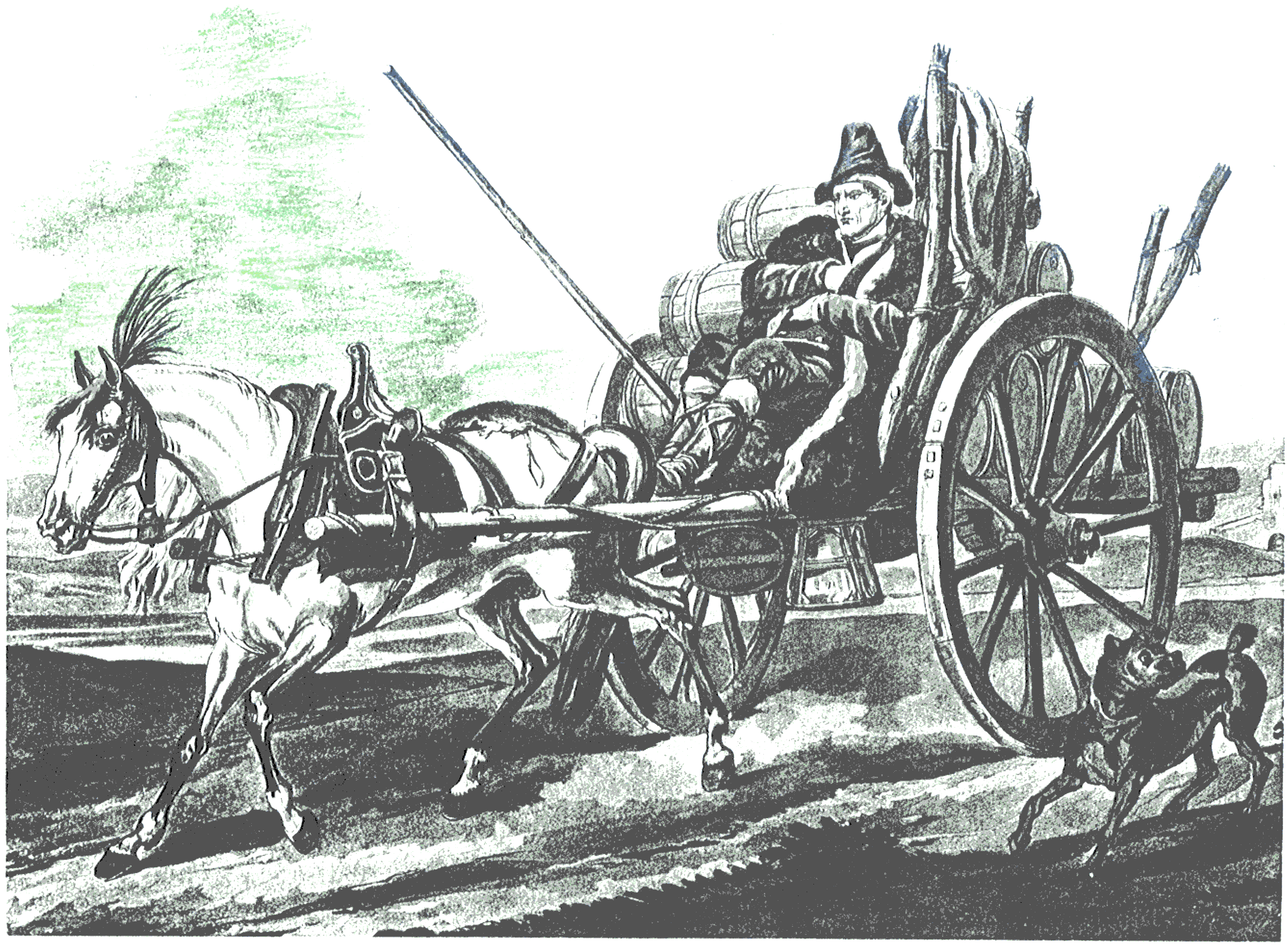Il carretto a vino
Buona
parte del vino prodotto nei Castelli subito
dopo la “svinatura”, cioè a marzo o aprile, a seconda della stagione,
veniva trasportato a Roma, da sempre insaziabile consumatrice di tale bevanda,
con i carretti a vino dai caratteristici “soffietti”.
Partivano a notte fonda in gruppi di tre o quattro per farsi compagnia durante il tragitto e, sul far dell’alba, erano fermi in lunghe code presso le barriere del dazio dove, i più accorti, avevano già fatto sdaziare il prezioso carico da ambulanti che avevano anticipato pagando per loro, dietro compenso di una non tanto modesta provvigione visto che molti di tali ingegnosi “banchieri” si arricchirono in breve tempo.
La
strada è longa e nun s’ariva mai
… Trotta morè, che tu sei un vanto, sei! Si arivi
presto, moro mio, ciavrai li
comprimenti che te farà lei
E
doppia biada che t’attripperai.
Tra
incitazioni come queste e schiocchi di frusta per accelerare l’andatura,
tintinnii di sonagliere e di ferriere, ogni carretto trasportava mezza botte di
vino suddivisa in otto barili, contenenti 60 litri ciascuno, con i
caratteristici bordi colorati e il fondo marcato dalle iniziali del
proprietario, più altri 10 barili da 50 litri e la “cupelletta” di
spettanza del carrettiere.
“Carretti d’una forma che hanno del grandioso ed insieme d’una semplicità antica”, scriveva Massimo d’Azeglio che, con la pignoleria del diplomatico, cosi completava la descrizione: “Due lunghi e forti stanghe posano da una parte su due ruote alte, e dall’altra, in linea orizzontale, sul dorso d’un cavallo, anche esso d’alta statura, quasi sempre nero morato, con un’incollatura, una testa, un tutt’insieme che ricorda i cavalli dell’arte antica. Il carretto non ha parapetti. Semplici traverse 10 connettono di sotto, sulle quali posano otto barili.”
|
|
Completavano
l’equipaggiamento, precisa Vincenzo Misserville in quell’ormai introvabile
numero che la rivista Castelli Romani nel 1964 dedicò allo (scomparso carretto a
vino), i (tortori) che, infilati al (molinello), stringevano a morte le funi per
impedire ai barili di muoversi, e dello stesso colore a strisce era anche la
(timonella), uno specie di lungo e robusto bastone forcuto posto sul fianco
destro del carretto, sia per reggere la stanga che per bilanciare il peso
durante le operazioni di scarico.
Sotto
il carretto, il corno di montone con l’olio per la lubrificazione dei mozzi
delle ruote e, non poteva mancare, un ferro di cavallo aruzzinito contro la
jella.