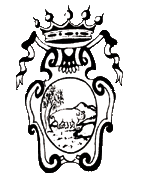
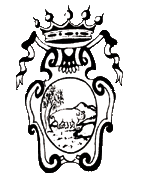
![]()
Albano laziale sorge sulle pendici dei Colli Albani a circa 25 Km. da Roma, lungo il corso della Via Appia. Per la posizione ottimale, a 400 m. sul livello del mare e ad appena 20 Km. dalla costa tirrenica, ha un clima temperato, caratterizzato da estati miti ed inverni moderatamente freddi. Le bellezze storico archeologiche, il lago, i boschi, la cucina tipica, caratterizzata anche dal celebre “vino dei Castelli”, le botteghe artigiane del centro storico, fanno di Albano laziale la meta preferita per il turista in visita ai Colli Albani. Culla della stirpe dei Latini che sparse 30 colonie nel Lazio e alla fine fu distrutta dall'ultima di esse: Roma. Sullo stemma municipale appare infatti il più celebre dei miti sacri ai Latini e ad alla mitica Albalonga, fondata secondo la leggenda da Ascanio, la bianca scrofa (Alba) che allatta trenta porcellini simboleggianti le trenta città della Lega Latina.

Questi simboli, nello stemma, sono posti sotto un’antica quercia ai bordi del lago e del monte Albano, dove Giove laziale aveva la sua sede ed il suo tempio massimo.
Sull'area dove Domiziano si fece costruire una villa da sogno, e quella dove Settimio Severo pose un grande accampamento di legionari: i "Castra Albana", chiamati anche di Minerva, sorge l'attuale centro urbano. Tali accampamenti erano formati da una serie di torri collegate da murature in blocchi squadrati di peperino tuttora visibili. L’approvvigionamento dell’acqua era garantito dal “Cisternone” che conteneva diecimila metri cubi d’acqua, esso risulta essere l’unica cisterna di età romana che oggi, dopo duemila anni, funziona ancora perfettamente. Le acque che l’alimentano per mezzo di un cunicolo sotterraneo provengono dalle sorgenti poste nel cratere del lago Albano e s’immettono scroscianti nelle cinque maestose navate della cisterna, lunga cinquantotto metri, larga trentadue e ripartita da ben trentasei pilastri. La nascita della città di Albano coincide con la soppressione dei Castra avvenuta nel 312 per ordine di Costantino, ma si deve ritenere che la città sia sorta, perché le famiglie dei legionari, gli addetti alla villa imperiale, gli artigiani e i commercianti necessariamente presenti hanno già costituito un nucleo abitato. Tra il 334 ed il 336, per volere dell'imperatore Costantino il Grande, fu edificata la Basilica di San Giovanni Battista, distrutta nel IX secolo, e riedificata da Leone III e dedicata a S. Pancrazio, attuale patrono della città.
Fin dall'età della Repubblica, i ricchi patrizi romani amavano risiedere all'Ager Albanus; tra questi avevano ville P. Terenzio Afro, M. Giunio Bruto, A. Aurelio, Sesto Tedio e Pompeo, la cui villa, attuale Villa Doria proprietà del Comune, passò da suo figlio all'Impero. Si ricorda la famosa Villa Domiziana, voluta da Domiziano che fece livellare e dividere il pendio del colle in quattro terrazze in cui dispose il palazzo, l’ippodromo, le cisterne ed il teatro, formando un nucleo che si può considerare il centro della sua villa di cui rimane ancora l'edificio, attualmente Chiesa, del Ninfeo della Rotonda.
Dai barbari
di Alarico, Genserico, Belisario, fino ai Saraceni e agli antipapi Guisberto e
Anacleto, e ai Romani nel 1168, Albano fu preda ambita dei vari condottieri e
protagonisti della storia nel primo Medioevo. Verso il 1178 compare a capo del
Borgo Giovanni Savelli, la cui famiglia tenne il possesso della città per
quattro secoli.
"La civitatem
Albanensem cum burgo et terris " risulta da una Bolla del 1217 data da
Onorio III, della famiglia Savelli, al locale Vescovo; Papa Onorio IV rimise
Albano tra i possedimenti della famiglia. Nel 1436, a causa della lotta tra il
Papato con Eugenio IV ed i Colonna alleati con i Savelli, Albano fu distrutta
completamente. Solo il Borgo rimase e una volta ripresosi, fu tolto da Sisto IV
ai Savelli e dato ai parenti Rovere. Nel 1501 Alessandro VI lo donò ai Borgia.
Nel 1503,
anno della morte del Papa, ritornò proprietà dei Savelli. Paolo III, nel 1607
conferì a Paolo Savelli, già Signore di Castel Gandolfo,
il titolo di Principe di Albano. Nel 1697 fu estinto ad un'asta della Camera
Apostolica. Nel secolo XVIII Albano fu nuovamente sede di residenza: ville delle
famiglie Altieri, Corsini, Doria-Pamphili. Con la Repubblica Romana gli
Albanensi si ribellarono e insorsero contro i Francesi, ma furono sedati da
Murat. Fece parte del Dipartimento del Tevere e fu capoluogo di Cantone.
Fu
inclusa nella Comarca quando ci fu la divisione in provincie dello Stato
Pontificio. Dal 1870 Albano entrò nella geografia del Regno d'Italia e nel 1872
ha assunto il nome di Albano Laziale. Nel 1894 viene inaugurata la ferrovia
Roma-Albano. Gli anni successivi vedono Albano assumere il ruolo di città
castellana con il suo patrimonio culturale, tradizioni e manifestazioni, ma le
vicende belliche del 1943-44 le impongono un duro tributo prima con i
bombardamenti aerei e poi con le battaglie e i cannoneggiamenti determinando la
distruzione di una parte della città e il
sacrificio di numerose vite umane.
Tra il XVII e XVIII secolo la città vede
emergere e poi maturare quello che diverrà il segno urbano più caratteristico:
la sua struttura innovante. Il realizzarsi nella sua parte alta del nuovo
Tridente, determina il convergere sul complesso di San Paolo e l’innervarsi
sul sistema urbano preesistente in connessione col tracciato della Via Appia. Un
telaio urbanistico, che guiderà e reggerà lo sviluppo della città fino al
nostro secolo, appoggiato al declivio alto del fronte verso il mare.
Esso si attesta verso Nord, attraverso la via
del "Borgo di San Paolo" (ora Via Murialdo) sul preesistente sistema,
confluendo nella piazza laterale al Duomo; mentre è congiunto verso Sud
attraverso l'attuale via Saffi direttamente sul tracciato della via Appia. Il
grande triangolo di strade dell’Albano barocca diviene così il contesto
portante della crescita edilizia per oltre due secoli. In questo periodo sorgono
la Chiesa di S. Paolo, la Chiesa della Immacolata Concezione, la nuova Sacrestia
della Cattedrale e il palazzetto al numero 91 di Via Saffi.
La vera fioritura edilizia si svilupperà
all'inizio del XVIII secolo con il passaggio di Albano dagli antichi proprietari
Savelli alla Camera Apostolica. Sorsero, infatti, la Porta Romana, la Chiesa di
S. Rocco, la Villa Altieri, Palazzo Doria, Palazzo Pamphili, il Palazzo
Camerale. Tutto questo fiorire di opere portò la città di Albano ad un
significativo livello architettonico ed urbanistico, tale da diventare in breve
tempo, più di altri centri urbani dei Castelli Romani, meta importante del
"Gran Tour" che scrittori e pittori intraprenderanno in Italia ed a
Roma nell’800. Tra questi ricordiamo Goethe, Stendhal, D’Annunzio, Ivanov,
Turgenev, Gogol, Piranesi, Kestner, Kuchler, Overback. Oggetto d’interesse
furono soprattutto le chiese e le ville di questo importante centro urbano.
Albano conserva ancora resti romani di Terme, tombe e di un anfiteatro, accanto
a chiese rinascimentali e campanili duecenteschì.
Le chiese trovano la loro principale
collocazione nel periodo tra il 600 e il 700 inoltrato, in cui il risveglio
dell’attività edilizia nei territori della Diocesi posti sui Colli Albani
portò alla costruzione di una nuova chiesa madre, in sostituzione di vecchie
chiese o la radicale ristrutturazione di quelle esistenti. Si tratterà di una
vistosa produzione che si ispirerà principalmente al tipo romano di Santa Maria
del Monserrato, soprattutto nella sua variante a presbiterio non absidato.
Chiese riferibili a questo impianto sono Santa Maria delle Grazie, San Francesco
d’Assisi, Immacolata Concezione, la facciata della Cattedrale di S. Pancrazio.
PARCHI E GIARDINI:
|
Villa Comunale ( ex Villa Doria) |
Villa del Vescovo ( Cecchina) |
|
Bosco Comunale |
Villa Contarini ( Pavona) |
|
Parco della Rimembranza |
Villa Adda |
|
Villa Ferraioli |
|
CHIESE E ISTITUZIONI RELIGIOSE
|
Curia Vescovile |
Via Alcide De Gasperi |
tel. 06/93210068 |
|
Caritas Diocesana |
Piazza della Rotonda |
tel. 06/ 9320100 |
|
Azione Cattolica |
Via A. De Gasperi |
tel. 06/ 9324078 |
|
Cattedrale di San Pancrazio |
Piazza L.A.Sabatini |
tel. 06/ 9324113 |
|
Santa Maria della Stella |
Via della Stella 5 |
tel. 06/ 9320819 |
|
Cuore Immacolato di Maria |
Via Risorgimento 11 |
tel. 06/ 9321910 |
|
Parrocchia di San Pietro |
Via Cellomaio 86 |
tel. 06/ 9321841 |
|
Sacro Cuore di Gesù |
Via Mole |
tel. 06/ 9360673 |
|
San Filippo Neri |
Via Nettunense |
tel. 06/ 9340172 |
|
S.Giuseppe Sposo di Maria |
Via Palermo |
tel. 06/ 9312325 |
|
Gesù di Nazareth |
Via Pantanelle |
|
|
Santa Maria della Rotonda |
Via della Rotonda |
tel. 06/ 9320100 |
|
San Gaspare del Bufalo |
Piazza san Paolo |
tel. 06/ 9322178 |
|
Sant'Eugenio |
Via Nettunense 50 |
|
ARTI E CULTURA
|
Museo Civico |
Via Risorgimento |
tel. 06/ 9323490 |
|||
|
Biblioteca Com.le Albano |
Via Risorgimento 2 |
tel. 06/ 9320534 |
|||
|
Biblioteca Com.le Cecchina |
Villa del Vescovo |
tel. 06/ 9340205 |
|||
|
Biblioteca Com.le Pavona |
Via Roma |
tel. 06/ 9313044 |
|||
|
Teatro Comunale Alba Radians ( in corso di ristrutturazione) |
Borgo Garibaldi 8-10 |
tel. 06/9320126 |
|||
|
Centrale |
Corso Matteotti 144 |
tel. 06/9320202 |
|||
| Comunale |
Via A. De Gasperi |
tel. 06/9323956 -
06/93295226 |
|||
|
Marini |
Via Nettunense 156 (Cecchina) |
tel.06/9340095 |
|||
| Moderno |
Corso Matteotti |
tel. 06/ 9320232 |
|||
| Marconi |
Via Risorgimento 125 |
tel. 06/ 9321809 |
|||
Le ville
|
|
Si trova tra il parco Vannutelli (nei pressi
del Ristorante Miralago) e il Monastero dei Cappuccini. Ha una superficie di 15
ettari, presenta caratteristiche di bosco di latifoglie, con molte piante ad
alto fusto che risalgono al bosco originario di quest'area dei Castelli. Il
parco pubblico naturale all'interno presenta sentieri che diventano sempre più
stretti per la vegetazione fino a diventare impercorribili. Il parco è
attraversato da un viale con ai lati grossi esemplari di lecci. Nel parco si
incontrano terreni di roccia vulcanica di tipo peperino intensamente alterato e
disgregato. In fondo al viale principale c'è l'ingresso “Belvedere”, una
specie di tempietto o cappella.
Ha una superficie di 10 ettari. Nato come parco
privato è divenuto poi Parco Comunale pubblico. Parco con una zona a giardino,
una parte a bosco con ruderi romani della villa di Pompeo e uno spiazzo
belvedere che guarda verso il mare. Vi si accede da più parti, ma 1'ingresso
principale è quello di Piazza Garibaldi. Parte del parco è di taglio moderno,
con siepi sagomate, aiuole fiorite e prato frequentemente tagliato, ma oggi non
lo vediamo nella sua originale estensione.
Lungo uno dei viali crescono annosi pini; un
largo viale è percorso da una galleria formata da grossi esemplari di lecci.
Nella parte bassa si sono rilevati molti alberi e cespugli che risalgono al
bosco originario. La zona circostante, i ruderi della villa dì Pompeo, è
quella in cui si è maggiormente mantenuta la fisionomia antica. La vegetazione
spontanea ha invaso i resti archeologici dell'originaria casa di Pompeo; tra
questi antichi sarcofagi, due leoni in pietra peperina e una vasca con coppa
centrale.
Similitudini sono state riscontrate tra la
villa in oggetto e Villa Venosa Boncompagni per il taglio triangolare e
1’analoga pendenza, per i viali sinuosi, i boschetti, le radure, i piccoli
specchi d'acqua. Il palazzo nel quale aveva sede la famiglia Doria è stato
demolito nel 1951 in seguito ai danneggiamenti causati dai bombardamenti del
1944. Un tempo sotto il Palazzo si trovavano due fontane. Sono stati rinvenuti
resti archeologici della Villa Romana di Pompeo del I sec. A. C. I ruderi della
villa romana presentano parti suggestive come criptoportici e terrazze, specie
dal lato del belvedere.
Interessante, inoltre, la passeggiata che nelle
direzioni SWE collega la zona del belvedere, estremo limite del parco, con la
parte adiacente al centro urbano. Fanno parte del giardino anche una fontana
moderna e una lapide ai caduti della Divisione Firenze (09.09.43).
La villa privata ha una superficie di due
ettari; diversi ettari sono occupati da un’area lottizzata a villini. Il resto
è destinato a parco pubblico Comunale. L’area privata adibita a giardino è
purtroppo circondata da piccoli villini moderni; essa comprende gruppi di vecchi
alberi sparsi e di vari cespugli, oltre che ampi spazi a prato. La villa è
situata ai limiti del centro storico, con ingresso dalla Via Appia (Borgo
Garibaldi) in direzione Ariccia. Una parte della villa è parco pubblico
comunale "Armando Carliseppe" e, ospita, nella zona esterna verso il
cancello d’entrata, l'Istituto Professionale per il Commercio e Turismo "Nicola
Garrone".
All'ingresso della villa si notano una siepe di
lauceraso, alloro e bosso, e un prato all'inglese con splendidi antichi
esemplari di conifere. Più avanti vi è una zona del parco in stato
d’abbandono con rami e alberi che ostruiscono il passaggio di una via interna.
La lottizzazione ha ridotto a poca cosa il giardino, un tempo splendido della
Villa Boncompagni. Cedri e tigli sono ora situati in giardinetti privati, palme
nel sentiero tra la villa privata e le villette. Nel 1855 I. Boncompagni si
dedicò alla coltivazione di piante esotiche arricchendo il parco di una rara
vegetazione e costruendo ben nove serre. Oggi restano solo piante ad alto fusto
e in parte la planimetria del giardino.
![]()
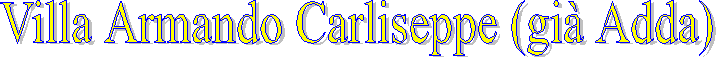 A
destra si apre l’ingresso di Villa Adda, ora dedicata alla memoria del Sindaco
A. Carliseppe; tra i sentieri si mostreranno pini secolari e cedri deodori.
A
destra si apre l’ingresso di Villa Adda, ora dedicata alla memoria del Sindaco
A. Carliseppe; tra i sentieri si mostreranno pini secolari e cedri deodori.
![]()
La Villa di Pompeo sorge sul territorio della Villa nota come ALBANUM POMPEI; Pompeo l’amava molto e vi dimorava a lungo. I ruderi della Villa si sviluppano su circa nove ettari di superficie, su terrazze digradanti da tutti e quattro i lati in modo da regolarizzare la pendenza. Proseguendo lungo il viale, a destra del piazzale, si osserverà il lato Nord-Ovest che era costituito da un lungo muro continuo decorato da lesene; dietro questo muro c’erano due corridoi: il primo allo stesso piano del giardino, il secondo ad un livello più alto e contiguo ad un portico. Sopra l’avancorpo venne alla luce, dopo gli scavi del1923-1924, un quadriportico ai lati del quale vi erano due ambienti absidali.
Tutto questo oggi non è più visibile: il piano è del tutto interrotto, tranne alcuni brani murari recentemente messi in luce e restaurati. Nella costruzione sono state distinte quattro principali fasi cronologiche: nella prima fase esisteva una Villa piuttosto modesta; nella seconda fase viene ricostruita, per opera di Pompeo, tra il 61 ed il 58 a . C. e in una terza fase furono costruiti il portico con le due stanze e l’emiciclo; l’ultima e quarta fase da ascrivere agli ultimi anni del I sec. d. C. nella quale furono operati restauri in opera mista di reticolati e mattoni.
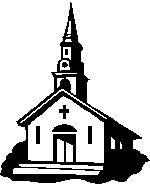
Originariamente dedicata a S. Giovanni
Battista, la basilica cattedrale fu fatta edificare dall'imperatore Costantino
sui resti di un antichissimo edificio che ospitava gli uffici della seconda
legione Partica. Il primitivo impianto basilicale, a tre navate con abside di
fondo, andò distrutto, assieme al vicino episcopio, in uno spaventoso incendio
agli inizi del IX secolo sotto il pontificato di Leone III, che ne curò la
pronta ricostruzione e la fece intitolare a S. Pancrazio Martire. Restaurata nel
1100, fu arricchita di opere ornamentali nel 1433 col Vescovo Pietro di Foix.
Nel 1562 Ottone Truchsess provvedeva a
rinnovare la pavimentazione, mentre nel 1570 il cardinale Giulio della Rovere
ricostruiva l’altare maggiore e la sacrestia. Alla fine del secolo XVI
l'antica chiesa a tre navate era ridotta alle fattezze di una sola navata
coperta a doppio spiovente. Con i restauri del 1688 furono costruiti un cimitero
e una sagrestia, dei quali non v'è traccia, perché in luogo del primo c'è la
navata di destra, mentre al posto della sagrestia sorge la cappella di testata
della medesima navata dedicata al Santissimo Sacramento.
Il cardinale di Albano Fabrizio Paolucci nel
XVIII secolo provvide alla sostituzione della vecchia facciata con quella
attuale. Nel 1826 fu possibile riaprire al culto la navata occupata dal
cimitero, quest'ultimo trasferito nei pressi della chiesa della Stella. Nel 1854
un ulteriore ed esteso intervento di restauro consentì di riaprire anche la
navata di sinistra, sino ad allora occupata dalla canonica e dalla cancelleria
vescovile. La cripta posta sotto il presbiterio fu costruita assieme alla
Basilica per potervi traslare le reliquie dei martiri della Catacomba di San
Senatore.
L’interno, allo stato attuale, è a tre
navate con presbiterio, abside, cappelle laterali, tre per lato, più due
cappelle di testata poste in corrispondenza delle navate laterali. All’esterno
la facciata che si deve all'opera del Buratti è scandita in tre campate; al
centro il portale d’ingresso e, in asse con questo, il finestrone, ora murato,
d'illuminazione della navata principale.
Con gli imponenti lavori di restauro del
1910/1913 si procedette a porre ai lati della gloria di S. Pancrazio, che
troneggia sull'altare maggiore, due tele raffiguranti il rinvenimento della
Croce ad opera di S. Elena imperatrice e la miracolosa visione che Costantino
ebbe a Roma, in prossimità di ponte Milvio, alla vigilia dello scontro con
Massenzio.
La chiesa è ricavata all'interno di un'aula
appartenente, un tempo, al complesso termale fatto costruire da Caracalla per i
legionari romani della Legione Partica accampati nel vicino castrum. Durante il
periodo in cui appartenne alla famiglia Savelli, all’originario impianto
termale furono aggiunti portici e forse un nartece d'ingresso, che ai primi del
1500 fu fatto spostare dal Cardinale Savelli per collocarlo sulla parete dov'era
l'abside, demolita per far posto al portale tuttora visibile sul fronte di Via
Cellomaio. In tale occasione fu costruito un nuovo altare posto ad occupare
1'intera parete di testata del nuovo presbiterio. Nel 1946, durante i lavori di
restauro, furono rimossi l'altare, per ripristinare l'originario ingresso, le
abitazioni e la cappella dei Savelli addossate alla Chiesa e al campanile
sul lato verso l'Appia.
Nel 1954 fu decretata la Parrocchia della
Chiesa di S. Pietro Apostolo, svincolandola dal Capitolo della Cattedrale di S.
Pancrazio, e dal 1981 la cura
pastorale è stata affidata all’opera della Chiesa della Madre Trinidad della
Santa Madre Chiesa. L'interno è un’area rettangolare coperte da travature
lignee e, in fondo su di un'ampia piattaforma, è il presbiterio sulla cui
parete di testata, al centro, un arco inquadra il Tabernacolo. All'esterno il
blocco dell’aula è coronato da una copertura a doppio spiovente ed è cinto,
in alto, da un cornicione romanico in beccatelli marmorei.
Attiguo al fianco destro è il campanile frutto
dei lavori condotti nel corso del XII secolo. Il fronte opposto a quello
principale, mostra ancora quello che doveva essere l'ingresso aperto dopo i
lavori promossi dal Cardinale Giacomo Savelli, assieme a consistenti tracce
della demolita abside e dell'apparecchio murario appartenuto all'originario
impianto romano.
Stratificazioni murarie romane e medioevali
caratterizzano il fronte lungo adiacente quello che fu il quartiere del
Cellomaio. Sul lato prospiciente l’Appia s'apre un ingresso i cui due stipiti
sono frammenti marmorei, adornati in basso rilievo, databili all'età di Traiano
(53 - 117 d.c.). Sulla parete di destra è raffigurato Sant'Onofrio Anacoreta e
Santa Margherita; più in basso la Flagellazione di Cristo con la Vergine e
Maria Maddalena. Sulla parete di sinistra vi è un altare collocato sopra un
sarcofago romano; sopra l’altare una tela raffigurante la Crocifissione. La
pala dell’altare maggiore raffigura la Consegna delle Chiavi.
SANTA
MARIA DELLA ROTONDA
L’edificio consacrato al culto della Vergine
Maria sin dal 1060, in origine era il ninfeo della villa di Domiziano posta ad
occupare i territori degli insediamenti storici di Albano e Castel Gandolfo;
successivamente riadattato ad impianto termale ad uso dei soldati della Legione
II Partica stanziati da Settimio Severo nei luoghi della citata villa. La Chiesa
d’Albano fu costruita sul ninfeo poiché questo era compreso all’interno del
castrum, le cui strutture vennero a costituire una parte delle donazioni di
Costantino alla nascente diocesi suburbicaria.
Al suo interno l'edificio si presenta in una
circonferenza su cui, quando era un ninfeo, si aprivano quattro porte di piccola
altezza, ognuna sormontata da una finestra ad arco a tutto sesto. Tali quattro
entrate si alternavano con quattro grandi nicchie ciascuna con una vasca. Il
tetto è una cupola costruita a strati orizzontali con foro nel mezzo, poggiante
su un grande cornicione, sorretto da otto lesene che scandivano l'alternarsi
delle porte con le nicchie. Quando S. Severo costituì la seconda Legione
Partica il ninfeo fu adibito a terme per i militi, ci furono varie
ristrutturazioni: fu chiusa la Porta innanzi e vi fu alzata una piccola ara in
peperino; furono tolte le vasche nelle sue absidi a fianco dell'altare.
La consacrazione alla Madonna del ninfeo romano
risalirebbe al secolo XI ma non si può escludere ch'esso fosse già prima
aperto al culto cristiano. Nel 1316 le grandi nicchie furono dedicate a S.
Giovanni Battista, S. Nicola, S. Bartolomeo e S. Agostino, mentre l'aula
dell'abside fu dedicata alla Beata Vergine. Nel 1616 tra due grandi nicchie fu
posto l'altare dedicato a S. Carlo Borromeo. Dal 1801 la chiesa fu affidata al
clero diocesano e nell’ambito dei festeggiamenti per l'incoronazione di Maria,
fu rifatta la facciata con un timpano sorretto da quattro lesene. Negli anni
trenta l'edificio fu ricondotto al suo originario aspetto, smantellando del
tutto la parte seicentesca ritenuta snaturante.
SAN
FRANCESCO D’ASSISI
Posta al termine di uno scenografico canale
prospettico rappresentato da una ripida scalinata con ai lati quinte di querce
secolari, è la facciata della Chiesa dei cappuccini che, insieme all'annesso
convento, si devono alla volontà di Flaminia Colonna Gonzaga. La consacrazione
dell’altare maggiore a S. Francesco e San Bonaventura avvenne nel 1625.
La
chiesa è posta all'interno di un canonico impianto chiostrale occupandone uno
dei quattro bracci. L'interno è ad aula rettangolare con cappelle laterali, una
per lato e presbiterio di fondo; i fianchi dell'aula sono scanditi in tre
arcate, di cui la prima e l'ultima sono cieche, mentre quella centrale inquadra
il vano rettangolare della cappella coperta da volta a crociera.
Il vano rettangolare del presbiterio è
inquadrato da un arcone impostato su prominenti spalle murarie. Sulla parete di
testata del presbiterio è l'edicola lignea dell'altare maggiore sotto cui è
stato collocato un nuovo tabernacolo. All’esterno l'attuale facciata è frutto
di un rifacimento ottocentesco; la quinta a capanna con lesene ai lati è
caratterizzata dalla tessitura a finto bugnato liscio e dall'inserto del portale
d'ingresso di foggia classicheggiante.
Sull’altare maggiore è una tela raffigurante
Flaminia Gonzaga con la Vergine e i Santi Francesco e Bonaventura. Nella
cappella laterale destra è il Presepe con la Vergine, San Giuseppe, il Bambino,
il bue e asinello. All’interno del coro è una tela raffigurante Cristo e la
Samaritana; nel vestibolo contiguo la cappella di sinistra è un affresco
raffigurante la Vergine, il Bambino e i Santi Pietro e Paolo.
La quinta chiesa, posta fuori della città nei
pressi del cimitero ipogeo di San Senatore, sulla via per Ariccia, è una chiesa
con Convento annesso, donata dai Signori di Albano Cristoforo e Ludovico Savelli
ai frati dell'ordine dei Carmelitani Scalzi. La dedica alla Vergine della Stella
si deve alla presenza dell'immagine della Madonna databile al XVI secolo, sul
cui manto brilla una stella polare. I frati ricostruirono il convento nel 1621,
ma nel 1673 quanto dì ciò che era stato costruito rovinò a terra ad eccezione
della cappella dove era stata custodita l'immagine della Vergine. La comunità
vide del miracoloso nell'evento e assieme al Comune si prodigò nella raccolta
d'offerte per la ricostruzione della chiesa i cui lavori terminarono nel 1687.
All'interno l'aula rettangolare è scandita,
alle pareti, in due campate dalla successione di due telai trilitici: i quattro
angoli dell'aula sono articolati da corpose partiture plastiche costituite da
paraste ripiegate poste a raggiungere in alto la fascia concava e modanata del
cornicione. I vani rettangolari del presbiterio e del retrostante coro sono
inquadrati dalla successione di sei prominenti pilastri murari mentre i due
ambienti sono separati dalla monumentale edicola dell'altare maggiore. L'edicola
si erge in altezza sino a raggiungere la quota del soffino ligneo configurandosi
come una presenza nettamente separabile dal resto del complesso.
Nella specchiatura centrale sono quattro
angeli, in stucco, posti a sostenere l’edicoletta della Madonna della Stella;
sopra i due accessi laterali al coro sono le sculture raffiguranti Santa Maria
Maddalena e Santa Teresa poste a sinistra e a destra dell'altare. Il soffitto
ligneo a cassettoni è articolato in tre riquadri al cui centro sono il
Monogramma della Vergine, lo stemma dei Carmelitani e al centro quello del
Cardinal Ottoboni.
Accanto alla chiesa è il recinto quadrangolare
del cimitero costruito dal comune nel 1883 con il quale si ricorda la grave
epidemia di colera del 1867 in cui
morirono la regina di Napoli Teresa d’Austria e lo stesso Cardinale Vescovo
d'Albano Ludovico Altieri. All'esterno la facciata è su due ordini sovrapposti
di lesene, separate da un cornicione; sul portale d'ingresso c'è una nicchia in
stucco nella quale è la raffigurazione della Vergine col Bambino.
Una leggenda popolare riporta come il sasso
incastonato nella parete vicino l'edicola della Vergine, fu scagliato da un
carrettiere in un momento d'ira contro la Sacra immagine. La Madonna della
Stella è situata nell’altare maggiore, mentre nel primo altare di destra c'è
una tela raffigurante la Madonna del Rosario con San Domenico e Santa Severa.Nel
secondo altare di destra è la Vergine, Sant’Anna e San Gioacchino.
La storia dell'abbazia di San Paolo ha inizio
nel 1282 quando il Cardinale Giacomo Savelli donava terreni di sua proprietà
all'Ordine Benedettino dei monaci di San Guglielmo. Contestualmente alla
donazione ebbero inizio i lavori di costruzione della chiesa ed annesso
convento. Ai Guglielmini fu affidato anche il romitorio, con annessa chiesa di
Sant'Angelo, posto sulle falde del lago nei pressi di Palazzola, fino al 1492
quando l’intero complesso passò nelle mani dei monaci Girolamini.
Più volte restaurata, la chiesa però mantenne
fino al 1769 la forma dell’impianto tardo medioevale caratterizzato da
un'austera facciata a Capanna con un oculo sotto il colmo ed all'interno,
copertura lignea a capriate stesa sul vano presbiteriale, portico esterno di
fronte la facciata. I Girolamini abbandonarono il monastero d'Albano che passò
alla proprietà della Reverenda Camera Apostolica sino al 1821, quando fu
assegnato alla Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue di Gesù
fondata da San Gaspare del Bufalo.
L’attuale aspetto della chiesa si deve ai
lavori di trasformazione promossi dal Cardinale Marco Antonio Colonna nel 1769. Alla primitiva aula furono
aggiunte ai lati una sequenza di cappelle e vestiboli mentre la copertura lignea
fu sostituita con altra a volta dal profilo ellittico. Ai due lati dell'aula
sono ricavate due profonde cappelle coperte a vela alternate, all'inizio e al
centro da vestiboli.
L'attuale chiesa di Santa Maria delle Grazie è
stata officiata dai Frati Minori Conventuali della Provincia Romana, ai quali
apparteneva assieme all'attiguo convento dal 1560, sino al 1999, data nella
quale è affidata alla cura pastorale del clero diocesano. Nel 1560 l’allora
Vescovo di Albano Girolamo Moroni, decise il trasferimento dei frati assegnando
loro la nuova sede per garantire l'assistenza religiosa ai pellegrini che si
recavano in venerazione di una miracolosa immagine della Madonna, scolpita in
bassorilievo su una lastra di marmo, ritrovata all'interno della preesistente
chiesa, forse Santa Maria Minore, che in occasione del ritrovamento prese il
nome di Santa Maria delle Grazie.
La chiesa è descritta a “foggia di capanna,
con un altare solo dedicato alla Madonna Santissima delle Grazie, bassa ed a
tetto senza cornicione e senza pilastri”. Nel XIX secolo fu ricostruito il
chiostro, agli interventi seicenteschi deve farsi corrispondere l'attuale
aspetto della chiesa, in particolare all'originaria aula si aggiunsero le
attuali cinque cappelle, tre sulla destra e due sulla sinistra, la sagrestia, il
coro, posto dietro l’altare maggiore ed il campanile. L’attuale facciata fu
eretta tra il secondo e il terzo decennio del XIX secolo in occasione d'un
esteso intervento di restauro portato a compimento nel 1832.
Il monastero delle Clarisse d'Albano è fondato
nel 1631 dalla principessa Caterina Savelli, che con 1'intenzione d'introdurre
nella città qualche regola di stretta osservanza propose ai Superiori quale
fondatrice Sr. M. Francesca Farnese Clarissa. La giustapposizione, per mezzo del
prominente arcone di separazione, dell'aula e del vano del presbiterio, la
modestia dei partiti architettonici e decorativi sono caratteri riscontrabili
nelle chiese dedicate a San Francesco in Albano e Genzano. Le precarie
condizioni di conservazione ed i notevoli problemi statici alle coperture resero
necessario un consistente intervento, condotto tra il 1998 e il 1999, di
restauro e consolidamento delle superfici e delle strutture della chiesa
occasione, anche, per adeguare il presbiterio alla liturgia del Concilio
Vaticano II.
L'intervento voluto dal Presidente della
Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, ha comportato un
esteso consolidamento delle coperture con introduzione di strutture in cemento
armato. La chiesa, comunque, non ha subito consistenti variazioni di forma
rispetto le origini: l'aula rettangolare è articolata, ai fianchi, in tre
specchiature intonacate da una successione di quattro disadorni telai posti agli
spigoli. Un arcone impostato tra due prominenti spalle murarie inquadra il vano
rettangolare del presbiterio coperto, come l'aula, da una volta a botte la cui
imposta è segnata, per tutto il perimetro della chiesa, da una cornice modanata
collocata in lieve aggetto. Ai lati del presbiterio due vestiboli divengono
un'appendice dell’aula a costituire le forme di una croce latina.
L'adeguamento liturgico si è tradotto nello spostamento in avanti della Mensa
Eucaristica appoggiata alla parete di testata del presbiterio di separazione tra
il coro monastico e la chiesa. L'apertura ricavata sul coro delle religiose è
stata chiusa con una lastra di cristallo dissimulata dalla raffigurazione in
ottone brunito dell'Albero della Vita. Posta sulla parete di testata del
presbiterio, in alto, è una tela raffigurante l'Immacolata Concezione. In una
nicchia, al di sopra del portale d'ingresso, vi è una raffigurazione scultorea
della Vergine.
![]()
Il disegno architettonico
compone una Chiesa ad aula con delle piccole cappelle laterali.
Caratteristica, sono le aperture nel muro tra coro e presbiterio e nel muro
sinistro che permettevano ai frati di seguire la Messa senza entrare in Chiesa.
La Chiesa possiede tutti requisiti diversi; elemento decorativo è una fascia
che corre lungo il muro, sotto a cui si aprono archi; le cappelle laterali hanno
volte a crociera ribassata. Il nostro sguardo può godere della semplicità dei
piaceri, attribuendo significati ultra - estetici alle forme, ai colori e alle
luci. Sull’Altare è posta una tela, un’opera firmata e datata nel 1618, ed
è incassata in una severa cornice lignea. Nel quadro è rappresentata la
principessa Flaminia Gonzaga, rivolta in preghiera verso la Vergine. Nella tela
si nota che la luce illumina le figure e si sorprende la sapienza tecnica
dell’artista. I personaggi si dispongono in modo da creare una sorta di
vortice. Nella Cappella laterale c’è un gruppo scultoreo con la Vergine, il
presepe in travertino e in marmo è opera di due artisti; il gruppo a linee e
volumi barocchi. Sulla parete c’è una tela seicentesca con San Bartolomeo e
affacciato sul chiostro c’è un affresco con la Vergine e il Bambino. La facciata della Chiesa conclude un iter che si era
preparato già da via San Francesco; conclusa la salita c’è una grande
scalinata che prepara fisicamente e spiritualmente all’incontro con
l’edificio Sacro. Un problema tecnico viene risolto con la consueta maestria
dell’architetto dell’ordine: con la creazione di strutture con linee
convergenti tutte al culmine del Timpano, strutture che costituiscono un insieme
scenografico. A questo prospetto del Convento si oppone quello interno che si
affaccia su un piazzale erboso: a destra c’è il Convento e di fronte un
oratorio dalle purissime linee seicentesche. ![]()
L’ interno
L’esterno